«È una sentenza ortopedica che riconduce la legge nell’alveo corretto della legittimità costituzionale». Commenta così lo stop della Consulta a sette profili della legge sull’Autonomia — dai Livelli essenziali di prestazione (Lep) alle aliquote sui tributi — il presidente emerito della Corte Costituzionale Cesare Mirabelli.
Cosa viene evidenziato nella sentenza?
«Il principio che domina è quello di sussidiarietà, che indica a quale livello di governo devono essere attribuite determinate funzioni. La sussidiarietà è bidirezionale: opera sia verso il basso, cioè dallo Stato centrale agli enti territoriali, sia verso l’alto. Era già in discussione un progetto presentato dal ministro Calderoli sulla Protezione civile e proprio su quel tema si è giocato un dibattito tra Regioni e parte del Governo sulla possibilità che lo Stato recuperi alcune funzioni trasferite alle Regioni. L’altro elemento importante chiarito nella sentenza è che non si può trattare di un trasferimento di materie, questo significherebbe una riforma “strisciante” dell’articolo 117 della Costituzione, ma di un’attribuzione di specifiche funzioni a singole Regioni quando questa sia giustificata da un miglioramento dei servizi, dalla più efficace azione che la Regione può compiere. E quindi non deve trattarsi di un atteggiamento “dismissivo” da parte dello Stato. Questa è la cornice nella quale vi può essere autonomia differenziata per singole regioni. Per ognuna deve essere motivata la possibilità e l’opportunità dell’autonomia differenziata. Per quello che riguarda la sussidiarietà, bisogna pensare all’esperienza del Covid e al riaccentramento di funzioni che alcune Regioni, come la Valle d’Aosta, pretendevano di esercitare. La sussidiarietà significa tornare alla competenza statale anche di funzioni attribuite alle Regioni quando questo sia necessario».
Una delle critiche più forti a questa legge è la disparità di trattamento tra le Regioni sui “Livelli essenziali delle prestazioni” (Lep).
«C’è un bilanciamento che porta ad affermare sia il principio autonomistico sia l’unità della Repubblica, entrambi previsti nell’articolo 5 della Costituzione. Il principio solidaristico riguarda gli individui ma anche le comunità. L’altro punto molto importante che deriva dalla sentenza è infatti il riequilibrio dei rapporti tra Parlamento e Governo, a garanzia dell’uguaglianza dei diritti. Per esempio, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali non può essere oggetto di una delega al Governo, che poi li può modificare anche nel tempo, ma è una competenza che è attribuita alla legislazione statale ed è una competenza del Parlamento. Su questo tema ci potranno essere anche altri sviluppi: per esempio il Governo non può stabilire i termini nei quali il Parlamento deve pronunciare osservazioni alla bozza di intesa. Infine, la legge per l’approvazione di intesa deve essere emendabile: non può il Parlamento “prendere o lasciare”. Al limite se emenda, si aprirà un nuovo negoziato tra Governo e Regioni. Perciò, viene ricordato nella sentenza che il Parlamento non deve essere silente e necessariamente annuente, ma che in qualche modo ha posizioni “protagonistiche” in queste procedure. Infine, anche sul piano finanziario, le Regioni che finora hanno tratto vantaggio della ripartizione delle risorse, a danno di altre, dovranno fare i conti con il fatto che questa diseguaglianza sarà colmata.
Adesso cosa accadrà? Si parlava di referendum?
Il nodo è: così come risulta dalla sentenza della Consulta e dalle illegittimità costituzionali dichiarate, il quesito referendario, cucito su un testo diverso rispetto a quello su cui le firme sono state raccolte, ha fatto venire meno, con modifiche che vanno incontro alle richieste dei referendari, l’oggetto del referendum o no? Il Parlamento che è invitato a intervenire potrà farlo in un arco di tempo così ristretto? Attenzione, potrà intervenire anche dopo la dichiarazione (in ipotesi) di ammissibilità costituzionale del referendum da parte della Corte. Perché, se la legge viene meno, sarà la Corte di Cassazione a ritenere che non c’è più la legge sulla quale il quesito era stato proposto. Questo può avvenire anche a ridosso dell’indizione del referendum».
Valeria Di Corrado
© RIPRODUZIONE RISERVATA
© RIPRODUZIONE RISERVATA
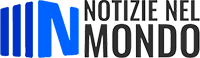
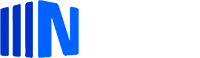



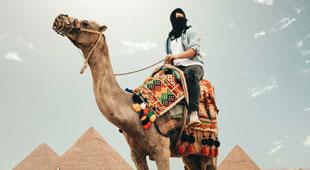








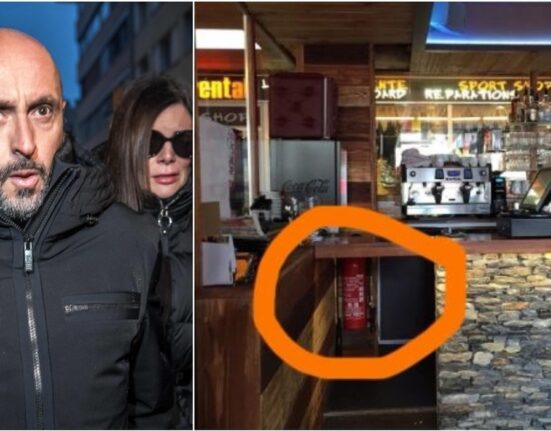
Leave feedback about this