Nello Cristianini, professore d’Intelligenza artificiale all’Università di Bath, nel Regno Unito, è a livello mondiale una delle fonti più autorevoli in questo campo di ricerca a cui dedica la vita.
Nell’ultimo triennio ha scritto, rivolgendosi a qualsiasi tipo di lettore, la trilogia delle macchine pensanti, edita da Il Mulino, formata da La scorciatoia (2023), Machina Sapiens (2024) e Sovrumano (2025). I suoi studi mettono insieme molte discipline e la ricerca sperimentale è a tutto campo come le riflessioni sull’impatto sociale, economico ed etico dell’Intelligenza artificiale (IA).
L’ha colpita la scelta di Papa Leone XIV di mettere al centro già nei primi discorsi l’IA?
«Mi sembra che il Papa veda chiaramente il punto centrale di questo momento: come già la rivoluzione industriale, anche questa nuova rivoluzione tecnologica potrebbe creare ingiustizie sociali, e ledere la dignità delle persone. Così il suo pensiero si rivolge a quelli che rischiano di restare indietro».
Oggi è possibile che una macchina sia più intelligente di un essere umano?
«Al momento non abbiamo una risposta conclusiva, ma non vedo ragioni per cui dobbiamo essere proprio noi il limite ultimo di ogni intelligenza, e dato l’immenso investimento e impegno di questi giorni, penso che potremmo essere l’ultima generazione a non conoscere la risposta. Ma si parla solo di intelligenza, ovvero abilità cognitive, non certo di coscienza o sentimenti».
In che modo l’IA è giunta alla capacità di ragionare?
«Ci sono diversi processi cognitivi che usiamo in situazioni diverse. Riconoscere un amico da lontano è diverso dall’organizzare una cena: il primo è immediato e non sappiamo spiegare come lo facciamo, il secondo richiede una serie di passaggi espliciti. “Ragionare” fa parte del secondo tipo, e richiede di procedere da premesse a conclusioni con una catena di passi rigorosi ed espliciti. Da qualche tempo è possibile insegnare ai modelli di IA a creare queste catene complesse di passaggi, fiutando anche le direzioni più promettenti in cui dirigersi per cercare una soluzione».
Esiste una giusta distanza possibile tra noi e le macchine?
«Dobbiamo trovarla, perché ci dovremo convivere. E si parte dai valori che vogliamo difendere, primo tra tutti la dignità umana, ovvero il fatto che il nostro valore non dipende dalla nostra utilità. Sono ottimista, se prendiamo la cosa sul serio».
C’è un limite nello sviluppo dell’IA?
«Senza dubbio: s’immagina una città come Roma se non avesse un codice stradale? Tutti hanno benefici quando ci sono regole chiare, anche quelli che si lamentano».
Quali sono gli aspetti più interessanti e al contempo problematici della relazione con l’IA?
«La cultura necessaria a comprendere questa scienza non fa parte del bagaglio educativo tipico, e quindi alcuni la vivono come una magia, altri come una minaccia o una truffa. È sempre meglio comprendere le cose e con i miei libri cerco di togliere la paura dell’ignoto. Nella nostra scuola dovremmo aggiungere una conoscenza più profonda della statistica e del metodo scientifico».
Come descriverebbe l’impatto dell’IA nelle attività quotidiane?
«La uso come tutti, per trovare più informazioni utili e per bloccare quelle inutili. Questo aumenta la mia autonomia. Mio figlio chiede all’IA di interrogarlo per allenarsi all’esame d’italiano, e devo dire che la macchina fa domande su Calvino molto migliori delle mie».
Le paure che nutriamo verso l’IA hanno fondamenta solide?
«Queste macchine sono capaci di risolvere problemi intellettuali, anche complessi, ma non hanno niente a che vedere con coscienza, emozioni, desideri. E nessuno propone di fare altrimenti. Eppure di questo sembra parlare la maggioranza dei commentatori: forse un segno che alcune paure derivano dalla scarsa conoscenza. Altre invece sono preoccupazioni appropriate: il rischio di competizione sul lavoro, quello di decisioni che potrebbero ledere i diritti di qualcuno, quello di concentrare molto potere in poche mani. Queste hanno basi solide, ed è giusto lavorare ora per evitare problemi domani».
Quale tipo di progresso anche morale e sociale è necessario per gestire questa nuova forma di potere?
«Non lo so, ci mancano ancora i concetti, ma dobbiamo parlarne presto. Senza leggi adeguate, chi è nella posizione di crearle potrebbe forse ritrovarsi con il potere di influenzare l’opinione pubblica, disporre di informazioni che altri non hanno, fornire servizi essenziali, e controllare una notevole forza lavoro. Non è troppo presto per parlarne: questi discorsi vanno fatti proprio quando sono ancora prematuri».
Nel mondo del lavoro rischiamo di apparire obsoleti rispetto alle macchine?
«Al momento abbiamo il caso dei traduttori, che hanno fatto questo incontro già molti anni fa: una macchina che esegue il 90% del nostro lavoro allo 0% del costo può modificare molte cose, anche se non è perfetta. A breve radiologi, programmatori e giornalisti si troveranno a fare discorsi simili ai traduttori».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
© RIPRODUZIONE RISERVATA
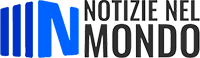
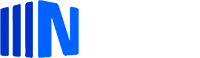



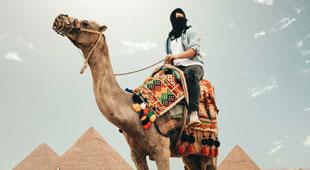









Leave feedback about this