La Banca d’Italia e il dipartimento di matematica del Politecnico di Milano hanno realizzato un nuovo percorso didattico online su «L’economia della transizione verde».
Il progetto
Il progetto è stato realizzato nell’ambito del progetto Edvance — Digital Education Hub per la Cultura Digitale Avanzata — finanziato dall’Unione Europea e nasce dalla considerazione del profondo impatto che i cambiamenti climatici hanno sulla nostra vita, così come la crescente frequenza di eventi estremi, nonché la distruzione degli eco sistemi. Fenomeni, questi, che riguardano oramai il nostro quotidiano e impongono un’urgente riflessione che coinvolge tutti.
A cosa è dovuto il cambiamento climatico? Quali sono le sue conseguenze economiche? Quali politiche si possono attuare per mitigare e adattarsi al cambiamento climatico? Cosa sta succedendo nel mondo della finanza verde? Cosa puoi fare anche tu per contrastarne gli effetti economici? Queste alcune delle domande a cui risponde il nuovo percorso didattico.
I video
Sono stati realizzati sei video di circa 7 minuti l’uno, che, attraverso un linguaggio semplice ma rigoroso, offrono una panoramica complessiva dei problemi da affrontare nella transizione verso un modello economico neutrale dal punto di vista climatico come previsto dagli obiettivi che l’Europa, insieme ad altri paesi nel mondo, punta a conseguire entro il 2050. Il percorso didattico consente di capire più nel dettaglio come funziona la transizione e come il sistema finanziario la supporta.
Economia e cambiamento climatico
Il percorso si concentra innanzitutto sulla relazione tra l’economia e le cause del cambiamento climatico, ricordando che il cambiamento climatico è causato da un aumento delle temperature terrestri. Molte delle attività umane, sia di produzione che di consumo, come ad esempio le produzioni industriali, i trasporti, il riscaldamento e il raffreddamento degli ambienti, rilasciano gas a effetto serra nell’atmosfera. L’anidride carbonica (CO2) rappresenta la maggior parte dei gas a effetto serra rilasciati nell’atmosfera, ed è generalmente il risultato della combustione di combustibili fossili (carbone, petrolio e gas naturale) prodotta dalle attività umane di produzione e consumo. Si stima che la CO2 possa rimanere in atmosfera per un periodo molto lungo, compreso tra 300 e 1000 anni. È con la rivoluzione industriale (l’invenzione della macchina a vapore e del motore a scoppio) che inizia l’impiego su larga scala dei combustibili fossili.
Gli studi del Panel di esperti di cambiamenti climatici delle Nazioni Unite mostrano che le temperature globali medie hanno cominciato a salire proprio a partire dalla rivoluzione industriale, con un’accelerazione negli ultimi 20 anni. A oggi l’aumento delle temperature medie è di circa 1,3 °C rispetto ai livelli preindustriali. La comunità scientifica internazionale è concorde nel ritenere che gran parte del riscaldamento globale osservato sia attribuibile alle attività umane, cioè a sistemi economici fondati sull’uso intensivo di combustibili fossili.
La transizione energetica
Ci si sofferma poi sulla transizione energetica, che ha a che fare con il modo in cui un sistema economico produce la sua energia. Nella storia abbiamo assistito a diverse transizioni energetiche (dal legno al carbone, dal carbone al petrolio e al gas naturale). La transizione energetica di cui si parla oggi è quella da fonti fossili (non rinnovabili), la cui combustione come abbiamo detto produce gas serra, a fonti rinnovabili (acqua, vento, sole ecc.), che invece sono pulite, cioè che non producono gas a effetto serra.
Secondo la comunità scientifica, infatti, per evitare danni consistenti in termini economici e di vite umane si deve contenere l’incremento della temperatura media rispetto ai livelli preindustriali attorno a 1,5 °C entro la fine di questo secolo. Per raggiungere questo obiettivo è necessario abbattere drasticamente le emissioni annuali di gas serra da subito per arrivare entro il 2050 a una situazione in cui l’attività umana non provoca modifiche al clima (cioè una situazione dove la quantità di gas serra emessa dalle attività umane è uguale a quella assorbita dall’ambiente naturale).
Gli investimenti
Nel percorso didattico si sottolinea quindi che per finanziare la transizione occorreranno ingenti investimenti. In termini economici, è molto impegnativo e costoso modificare i processi produttivi. Per arrivare alla neutralità climatica occorre trasformare profondamente i nostri modi di produrre e consumare e ciò richiede enormi investimenti in tecnologia e infrastrutture. Tutti i settori economici sono coinvolti in questa trasformazione, in particolare quelli che utilizzano di più l’energia e i derivati delle fonti fossili e che producono più emissioni: quindi la transizione riguarderà in maniera più intensa la produzione di energia, i trasporti e i settori industriali più energivori come ad esempio cemento e acciaio. Anche le nostre abitazioni devono trasformarsi, per diventare sempre più efficienti dal punto di vista dei consumi energetici.
Questi investimenti sono e saranno finanziati sia attraverso risorse pubbliche (proventi derivanti dall’assegnazione di quote per inquinare, tassa sul carbonio), sia attraverso la finanza privata.
La finanza sostenibile
Un capitolo è dedicato poi alla finanza sostenibile. Il processo di transizione verso modelli di sviluppo più sostenibili (non solo dal punto di vista ambientale, ma anche sociale e di governo societario) è accompagnato anche dalla rapida crescita della finanza sostenibile, un ecosistema in cui gli operatori tengono conto dei profili di sostenibilità (ambientali, sociali e di governo societario) nelle decisioni di investimento.
Il greenwashing
Si parla inoltre di greenwashing. Nella selezione degli strumenti finanziari cosiddetti “verdi” occorre anche tenere in considerazione il rischio di greenwashing, cioè la possibilità che l’emittente presenti come ecosostenibili attività o prodotti che invece non lo sono. Per tutelare gli investitori da questo rischio e definire una classificazione affidabile, la Commissione europea ha elaborato una tassonomia delle attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale, cioè un sistema di classificazione che elenca le attività economiche ritenute ecosostenibili in base a precisi indicatori e valori di riferimento. Quindi gli investimenti che vogliono avere l’etichetta “verde” dall’Europa devono essere allineati a questa tassonomia.
Cosa può fare ciascuno di noi
Infine ci si sofferma su come ciascuno di noi può contribuire al successo della transizione climatica, che dipende anche dalle nostre scelte quotidiane di consumo, di utilizzo dei mezzi di trasporto, di utilizzo e cura delle risorse naturali. Piccole azioni quotidiane contribuiscono alla conservazione della natura e della biodiversità, elementi essenziali per contrastare il cambiamento climatico e contribuire al benessere di tutti.
I quiz
I video sono corredati da quiz di autovalutazione e da esercizi e materiali aggiuntivi pensati per la scuola secondaria di II grado e per l’utilizzo in classe da parte dei docenti. Il percorso di formazione on line è accessibile dai siti web del Politecnico di Milano, della Banca d’Italia e del QFinLab.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
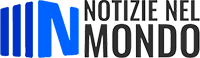
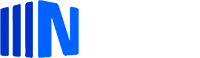



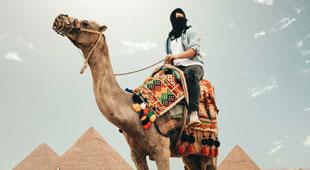









Leave feedback about this