Papa Leone XIV dal balcone di San Pietro ha concesso l’indulgenza plenaria alla folla che si era radunata in piazza per attendere l’ «Habemus Papam». Si tratta di un concetto centrale nella dottrina cattolica, legato alla remissione totale della pena temporale dovuta per i peccati già confessati e perdonati.
Indulgenza plenaria, cosa è
Un fedele con la confessione ottiene il perdono dei peccati. Per la teologia cattolica resta però una pena temporale, una sorta di conseguenza «spirituale» da espiare. Questa può essere cancellata completamente con l’indulgenza plenaria, che sarebbe una pulizia totale del proprio spirito. La facoltà di concedere le indulgenze spetta al papa e alla Penitenzieria Apostolica. Vale sia per il fedele che per un’anima del purgatorio. Era stata concessa anche con l’apertura di Giubileo 2025.
Cosa serve per ottenerla
Il fedele deve essere in stato di grazia, ovvero non avere peccati mortali non confessati. Inoltre deve confessarsi sacramentalmente e fare la comunione entro pochi giorni, oltre a pregare secondo le intenzioni del Papa.
La storia
Anticamente le pene venivano comminate in giorni, con penitenze di un periodo di 40 giorni, 100 giorni o anche tutta la vita. Le indulgenze sono nate nei primi secoli cristiani come sconti penitenziali. Nel Medioevo si sono diffuse largamente e furono una delle cause scatenanti della Riforma protestante visti gli abusi nella vendita. Il Concilio di Trento (1545-63) ha riformato profondamente la pratica. Oggi le indulgenze parziali non sono più distinte tra loro in base a una quantificazione temporale (giorni, mesi, anni), ma si fondano sul principio secondo cui la remissione della pena temporale ottenuta spontaneamente dal fedele attraverso l’azione compiuta serve da misura per la pena che l’autorità ecclesiastica aggiunge con l’indulgenza stessa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
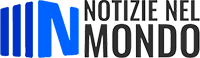
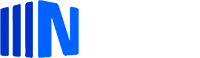



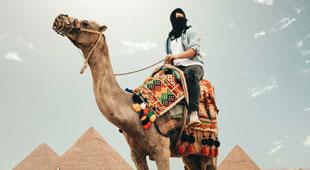









Leave feedback about this