Si comincia con l’Altare della Patria. Sergio Mattarella oggi sarà lì, insieme a Giorgia Meloni e ai presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. Poi, in questo 25 aprile dell’ottantesimo anniversario, il Capo dello Stato si sposterà a Genova per un’altra cerimonia. Nella città che si liberò da sola e dove i partigiani non ebbero bisogno dell’aiuto delle truppe alleate. A causa della preparazione delle esequie di Bergoglio, sarà quella di Mattarella una visita modificata ma molto importante. Prima al cimitero monumentale di Staglieno, per deporre una corona al campo dei partigiani. Poi la cerimonia al Teatro Nazionale Ivo Chiesa, dove il Presidente della Repubblica farà un discorso e assisterà allo spettacolo teatrale D’Oro: «Il sesto senso partigiano». Annullata invece la visita a Villa Migone, luogo simbolico della Liberazione di Genova, dove il generale tedesco Meinhold firmò la resa davanti al Comitato di liberazione nazionale.
IL REVISIONISMO
E dunque un festeggiamento particolare per Mattarella questo dell’ottantesimo del 25 aprile del ‘45. Questa data del calendario civile della nazione è molto cara al presidente. E per accorgersene basta compulsare il libro appena pubblicato da Interlinea che raccoglie i suoi discorsi sulla Liberazione lungo questi dieci anni di presidenza della Repubblica. Ne viene fuori un racconto di pedagogia civile molto adatto, anche per i giovani, per capire il significato di quell’evento fondante della nostra democrazia. Come scrive Gianfranco Astori, consigliere di Mattarella per l’informazione, nella nota finale a questo volume intitolato «La nostra libertà», «Il 25 aprile è la festa della libertà di tutti gli italiani, il momento e il luogo di quanti, cittadini e cittadine, s’incontrano nella Costituzione della Repubblica».
Ogni discorso sviluppa un aspetto particolare del 25 aprile, incominciando dal primo, del 2015, quando il presidente chiuse i conti con il cosiddetto revisionismo. Sì, l’analisi della storia va fatta sempre e va fatta tutta, ma il giudizio storico sul fascismo, per Mattarella, deve contenere profondamente la differenza tra chi stava dalla parte del torto e chi stava dalla parte della ragione, tra chi era per il totalitarismo mussoliniano e hitleriano e chi per la libertà, per i diritti, per la democrazia. Affrontare lo studio della storia tutta quanta e in maniera approfondita, questa la morale degli interventi presidenziali, aiuta a comprendere il passato e anche il presente.
Lo scorso anno, per il 25 aprile Mattarella parlò della «Resistenza civile: le donne e gli uomini che rischiarono la vita». Parole pronunciate a Civitella in Val di Chiana dove avvenne uno dei peggiori eccidi nazifascisti. E ha raccontato il presidente delle donne, degli anziani, dei sacerdoti, dei ragazzi e dei bambini che vennero trucidati il 29 giugno del ‘44. Parla molto di persone, oltre che di valori, Mattarella in questi suoi discorsi. Il filo che li attraversa è quello che serve a evidenziare il suo approccio che è questo: non furono pochi (come molto revisionismo si impegna a dire di continuo) i partigiani, furono tanti nel senso che un’infinità di italiani di ogni ceto e di ogni credo politico, di ogni settore civile — i preti, le suore, i militari, i contadini, gli operai, i professionisti, gli insegnanti, i medici, gli operatori sanitari: il largo corpo dell’Italia che non accettava il sopruso e la violenza — diedero il loro contributo, rischiando di morire e venendo spesso uccisi, aiutando i combattenti, dando ricovero a chi scappava dai nazisti e dai fascisti, immolandosi per i propri concittadini, resistendo spesso in maniera discreta, alla lotta di liberazione. «La Resistenza in armi — disse Mattarella nel 2015 a Milano — e la lotta partigiana, emblema della riscossa nazionale contro gli oppressori, non furono espressioni di avanguardie separate». Proprio così: i legami di solidarietà tra chi impugnava le armi e chi aiutava i partigiani e i patrioti in lotta furono il cemento della vittoria e la premessa dell’Italia che arriverà.
IL TRICOLORE
L’Italia profonda che stava dalla parte giusta, questo interessa a Mattarella di fare emergere. Ossia il patriottismo di tanti, il sacrificio di un popolo che meritava la libertà e fece di tutto, nei limiti del possibile, per procurare la democrazia. «La riconquista della patria» s’intitola uno di questi discorsi, quello tenuto a Cuneo il 25 aprile del 2023. O ancora: «Uniti intorno al tricolore». E via così. Un discorso cruciale quello a Vittorio Veneto nel 2019. «Voglio ricordare — disse Mattarella — le parole di Teresio Olivelli, partigiano ucciso a bastonate nel lager di Hersbruck: «Lottiamo giorno per giorno perché sappiamo che la libertà non può essere elargita dagli altri. Non vi sono liberatori. Solo uomini che si liberano». E insomma, gli Alleati ci hanno liberato ma ci siamo liberati anche da soli.
Un’altra caratteristica della narrazione mattarelliana sul 25 aprile è quella di legare la Liberazione del ‘45 agli scenari attuali, all’Europa di oggi e al mondo che non deve piegarsi all’autoritarismo e al nazionalismo risorgenti. La storia come storia contemporanea. E la lezione dei resistenti che non va interrotta, perché interroga anche il futuro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
© RIPRODUZIONE RISERVATA
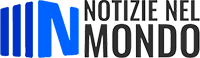
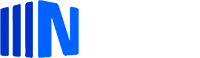



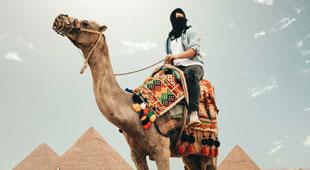



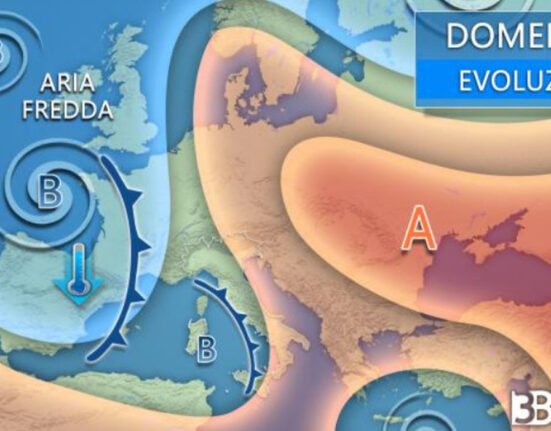





Leave feedback about this