La febbre referendaria è quella che accompagnerà l’Italia da qui ai prossimi due anni. Una overdose di consultazioni. Addirittura quattro, su tutte le materie e su leggi costituzionali — quindi referendum confermativo senza quorum come previsto dalla Carta del 1948 in caso di mancanza di maggioranza qualificata in Parlamento su riforme di questo tipo — e su leggi ordinarie. E insomma, tutti alle urne sul premierato e sulla riforma della giustizia, comprensiva di separazione delle carriere e nuove regole per il Csm, e pro o contro l’autonomia differenziata e il jobs act. La logica del contro e non dell’insieme è quella che, in appuntamenti così, si prenderà la scena del Paese e già è cominciato questo intreccio di campagne referendarie che andranno anche molto al di là delle delicatissime materie in gioco.
L’opposizione, che su molti temi non è unita, vede i referendum come uno strumento di aggregazione interna, come la maniera per creare il campo largo, o magari larghissimo, in vista delle Politiche del 2027. La maggioranza nei referendum cerca invece la conferma della propria forza, li vede come sondaggi per rassicurare se stessa e i propri elettori.
La febbre referendaria rischia comunque di non fare bene all’Italia, perché la spacca in un momento in cui sarebbe necessaria la massima condivisione per affrontare tutti insieme, come Sistema Paese, le sfide nazionali e internazionali che la storia ci offre e che possono apparire traversie ma anche rivelarsi grandi opportunità. Eppure, la sinistra pensa solo a quelli: ai referendum, appunto. E il centrodestra poteva fare qualcosa di più per evitarli. Basti pensare che, per esempio sul premierato, non ancora approvato in via definitiva, si sta facendo l’opposto di quanto si fece per la Costituzione del 1948 che fu un compromesso nobile e insieme pragmatico, dopo che Alcide De Gasperi aveva scaricato i comunisti dal governo e mentre infuriava, anche nella società italiana, la Guerra Fredda. Ma allora, evidentemente, il Parlamento funzionava, mentre la febbre referendaria, la scorciatoia dei referendum, è la prova di un Parlamento che scarica i suoi problemi sul Paese e questo non è un buon segno di fisiologia istituzionale.
Quando questioni così complesse vengono messe nelle mani del popolo, spesso poco informato e bombardato dalle varie propagande in campo, oltre al rischio di creare fratture non richieste dai cittadini (vogliosi di stabilità, di serenità e di avere un Paese forte del suo standing internazionale e capace di crescere economicamente) c’è il pericolo di dare un’impressione controproducente. L’impressione che la politica, quella che dovrebbe professionalmente risolvere i problemi, deleghi la loro risoluzione ai cittadini dando loro una dimostrazione di impotenza che è l’alimento di ogni populismo. Scaricare le responsabilità di certe scelte nelle urne referendarie significa liberarsene e non dare, da parte dei partiti all’opinione pubblica, un messaggio di forza riformatrice. Il coraggio di mettersi in gioco secondo le proprie capacità negoziali e con un surplus di creatività (non si sa per esempio al momento quale sarà la legge elettorale connessa al premierato), invece di alzare facilmente muri e contro-muri, è l’unico antidoto alla febbre referendaria. Ma la politica non vuole ingoiare questa pillola che le farebbe molto bene.
Oltretutto l’arma, pur così tanto accarezzata, del referendum è in realtà spuntata, almeno nei casi di consultazioni non su leggi costituzionali. Se sul premierato e sulla giustizia non è l’opposizione a chiedere le consultazioni, ma è la Carta a prevederle in caso di maggioranze non qualificate, sugli altri due è la sinistra a volere le urne, senza calcolare un dato di fatto. Nei referendum abrogativi il quorum è stato raggiunto una sola volta negli ultimi 25 anni. Fu nel 2011 (con il 54,8 di affluenza) per i quesiti sull’acqua e su altre materie. E c’è anche da ricordare l’esempio del referendum del 18 aprile del 1999 sull’abolizione della quota proporzionale nel Mattarellum. Il quorum in quel caso non venne raggiunto per un soffio. Votarono il 49,58 per cento degli aventi diritto e la non partecipazione praticamente totale dei poco più di 2 milioni di italiani all’estero fu determinante. Oggi che gli italiani all’estero sono quasi sei milioni, e storicamente non mobilitabili nei referendum, come si può pensare — e ci riferiamo ai quesiti sull’autonomia differenziata e sul jobs act — che si rechino in massa alle urne? La sinistra di questo non si preoccupa? Dovrebbe.
Non solo la sinistra ma tutti e proprio tutti dovrebbero pensare che l’intero corpo elettorale già si è mostrato sempre più stanco, e le ultime Europee ne sono la riprova, di — per usare una spiritosa espressione del vignettista Altan — «commettere il proprio di diritto di voto». C’è una sorta di fiacchezza nella partecipazione politica che non andrebbe stressata troppo. E rischia di essere un errore quello di credere che quanto più si alzerà il livello dello scontro tra le propagande — il mio No urlato contro il tuo Sì, la mia demonizzazione contro la tua, «Voi non volete cambiare niente!», «E voi volete una deriva autoritaria e ammazza-Italia!», i comitati contro i comitati, i costituzionalisti contro i costituzionalisti, le crociate contro le crociate — tanto più i cittadini saranno attratti alle urne. Semmai, occhio al paradosso per cui si inneggia sempre alla centralità del Parlamento e poi lo si scavalca rivolgendosi direttamente al popolo ma il popolo certi giochi auto-referenziali della politica li ha imparati a conoscere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
© RIPRODUZIONE RISERVATA
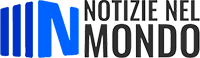
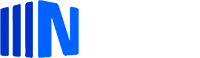



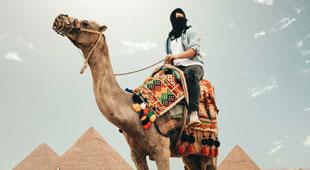









Leave feedback about this