Sosteneva Iosif Brodskij che «la storia, senza dubbio, è destinata a ripetersi: in fondo, al pari degli uomini, non ha molte scelte». Un monito da ricordare. Nel male — gli oltre cinquanta conflitti in corso nel mondo lo dimostrano — ma anche nel bene. Perché alcune delle sfide che oggi si presentano all’Europa e all’Italia, dalla doppia transizione digitale e ambientale all’intelligenza artificiale, richiamano, seppur in forme diverse, snodi analoghi già attraversati e superati e, dunque, certe lezioni del passato possono rivelarsi sorprendentemente attuali.
Dopo il crollo del muro di Berlino nel 1989 l’Europa fu posta davanti a un bivio: sostenere la riunificazione tedesca e accelerare sull’integrazione oppure lasciarsi divorare dalle forze centrifughe. La strada della moneta unica, imboccata con il Trattato di Maastricht, segnò la vittoria della prima soluzione. Ma non fu una resa alla «nuova» Germania di Helmut Kohl, ossessionata dai parametri rigidi di convergenza come garanzia della stabilità dei prezzi. Guido Carli, ex Governatore della Banca d’Italia dal 1960 al 1975 e allora ministro del Tesoro, tra i negoziatori del Trattato, si batté con forza contro un’interpretazione ideologica di quei parametri e contro la loro rigidità, che avrebbe insensatamente penalizzato l’Italia. L’allora ministro degli Esteri, Gianni De Michelis, riferì anni dopo la frase che Carli ripeteva ai tedeschi: «Non ci sono numeri magici, per cui il 3,1 è male e il 2,9 è bene».
Grazie alla sua ostinazione illuminata e alla convinzione che l’Europa non potesse risolversi in un’unione delle percentuali e delle regole ma dovesse rappresentare la «casa comune» dei popoli, orientata alla crescita e al lavoro, ottenemmo la clausola che consentiva agli Stati di impegnarsi in un percorso di avvicinamento tendenziale alla soglia obiettivo del rapporto debito-Pil (60%). E salvammo il progetto che portò in seguito all’adozione dell’euro. Nel 1993, un anno dopo la firma a Maastricht «con la mano tremante», Carli lasciò ai posteri questa riflessione, che somiglia a un testamento: «Il nostro interesse di lungo periodo è la costruzione di una federazione europea basata sul principio dello «Stato minimo», tenuta unita da una politica monetaria, da una politica estera e da una difesa unitaria. Sarebbero gli Stati europei, singolarmente, in condizioni di resistere agli urti che provengono da un mondo esterno che cade in frantumi?». Una domanda di straordinaria attualità.
Durante la crisi del 2008-2012 fu un altro esercizio di unità all’insegna della flessibilità a rivelarsi determinante: il whatever it takes di Mario Draghi mise fine a un lungo periodo di risposte sbagliate dell’Europa alla tempesta, dettate dal prevalere della tecnocrazia sulla lungimiranza politica. L’eredità di Carli rimaneva viva.
Oggi l’Unione europea gioca un’altra partita «esistenziale», per dirla con le parole dello stesso Draghi nel Rapporto sulla competitività europea. Un testo che, tra i suoi «diversi importanti spunti», come li ha definiti il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segnala ha affermato il premier — «la necessità che l’Europa preveda strumenti adatti a realizzare le sue ambiziose strategie — dal rafforzamento dell’industria della difesa fino alle doppie transizioni — senza escludere aprioristicamente nulla, compresa la possibilità di un nuovo debito comune».
Sono di nuovo le sterili inflessibilità e gli arroccamenti i principali nemici del sogno europeo. L’Italia, oggi come allora, continua a combatterli. Non c’è soltanto il Governo a mettere in guardia contro le derive e le contraddizioni. Non si stancano di ribadirlo anche gli industriali, dal presidente di Confindustria Emanuele Orsini al presidente di Assolombarda Alessandro Spada, che proprio qualche giorno fa ha invocato un cambio di rotta nella regolazione, reclamando «un’Europa pragmatica, al servizio della crescita e non della burocrazia». È ciò che avrebbe chiesto Carli. Per questo, davanti alla minaccia di una transizione verde imposta ciecamente senza considerare i costi per le imprese e i lavoratori, di fronte al tentativo di iper regolare l’intelligenza artificiale senza preoccuparsi di dotarsi delle competenze per svilupparla senza subirla, riteniamo che la ricetta sia ancora una volta quella dello statista: meno ideologia, più etica; abbandono delle astruserie ragionieristiche, crescita come stella polare. Parleremo anche di questo il 22 novembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma in occasione della Convention inaugurale della Fondazione Guido Carli «Intelligenza da vendere. Etica e impresa al tempo dell’IA», con Padre Paolo Benanti, Giampiero Massolo, top manager e imprenditori di primo piano. Lo faremo un mese prima dell’apertura del Giubileo della Speranza, perché la nuova frontiera dell’algoretica raccomandata da Papa Francesco diventi una bussola per tutti: amministrazioni pubbliche, aziende, società civile.
La storia è destinata a ripetersi. Ma può essere una fortuna, se sappiamo coltivare la memoria.
*Presidente della Fondazione Guido Carli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
© RIPRODUZIONE RISERVATA
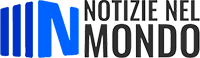
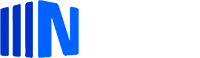



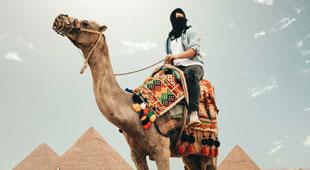








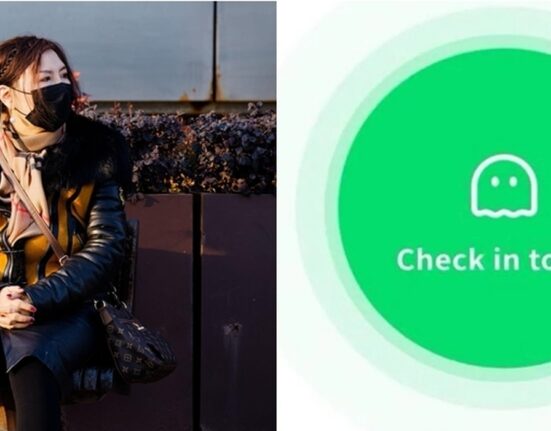
Leave feedback about this