Nell’era dell’intelligenza artificiale l’arrivo sorprendente di Leone XIV sul Soglio di Pietro si può anche leggere come un formidabile segno dei tempi.
Uno dei cardinali elettori che durante i giorni del conclave si trovavano nella Sistina ha commentato che con l’introduzione della tecnologia che sta rivoluzionando l’interazione uomo-macchina, la Chiesa non poteva che eleggere l’unico Papa della storia laureato in matematica e discipline Stem. Quando si dice la provvidenza. Naturalmente non si sa se la scelta sia stata facilitata anche da questo fattore, tuttavia delle sfide originate a livello planetario dall’intelligenza artificiale ne avevano parlato a lungo diversi cardinali nel corso delle Congregazioni generali, vale a dire le riunioni a porte chiuse che si svolgono prima del voto. Durante questi scambi liberi e segreti si sarebbero registrati più interventi tesi a sollevare il problema antropologico legato agli algoritmi, agli umanoidi e, in generale, a come questi strumenti sofisticati rischiano di stravolgere il rapporto tra gli stessi esseri umani, modificare i nostri processi cognitivi e persino causare in futuro disordini a livello planetario, provocare masse di disoccupati, incidere nella struttura della società.
IL PASSATO
Si tratta di qualcosa di enorme e paragonabile a quello che già accadde a metà dell’Ottocento con la rivoluzione industriale che arrivò ad alterare per sempre la faccia dell’Europa con la nascita di una nuova categoria sociale, quella dei proletari, masse allora senza diritti, proprietari solo della propria forza lavoro. Le campagne si andarono svuotando per concentrarsi nei poli industriali cittadini, vi fu una migrazione economica massiccia alla ricerca di lavoro nelle fabbriche. Pensando a questo passaggio storico e intravedendovi similitudini prospettiche Leone XIV ha scelto – anche per questo motivo – di prendere il nome del suo predecessore Papa Pecci, il pontefice che promulgò la Rerum Novarum fondando la Dottrina Sociale della Chiesa, ispiratrice del network delle banche rurali cattoliche, dei sindacati bianchi, delle cooperative nonché di un vasto movimento bianco che agiva per la difesa della dignità umana dei lavoratori. Era la risposta della Chiesa alle idee socialiste che si stavano diffondendo con il Capitale di Marx. Naturalmente Papa Pecci all’epoca fu assai criticato dai liberali perché non avrebbe dovuto occuparsi dei salari, delle ore lavorative e del fatto che anche i bambini erano costretti a lavorare nelle filande anche 12 ore al giorno.
IL FINE
«La Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un’altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell’intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro» ha detto Prevost in uno dei suoi primissimi interventi. Naturalmente la Chiesa ha iniziato a riflettere su questa nuova frontiera almeno una decina di anni fa mettendo al centro la questione antropologica, vale a dire: se l’uomo, come uomo, nel contesto del progresso tecnologico, diventerà “veramente migliore, cioè più maturo spiritualmente, più cosciente della dignità della sua umanità, più responsabile, più aperto agli altri, in particolare verso i più bisognosi e più deboli”. L’argomento è stato al centro di studi nelle università pontificie, di convegni all’Accademia pontificia delle scienze sociali, di documenti da parte del Dicastero della Fede. Il fatto è che la Chiesa non può occuparsi della cosiddetta intelligenza artificiale generativa. «Anche se è impossibile giudicare i processi attuali a causa della mancanza di distanza storica, i segnali indicano la fase iniziale di una rivoluzione informatica e tecnologica che ha realizzato l’intelligenza delle macchine» ha affermato di recente Ferenc Patsch, professore di Teologia fondamentale alla Pontificia Università Gregoriana, mettendo in evidenza che il nodo principale riguarda l’autocoscienza, che le macchine, anche le più sofisticate, non possiedono, nonostante la ricerca abbia già prodotto risultati eccezionali.
LO SVILUPPO
Le sfide sono parecchie e l’orizzonte resta incerto. L’IA ha persino un significato geopolitico immenso e, anche in questo caso, la Chiesa ha sempre messo in luce che chi vincerà la corsa agli armamenti dell’IA sarà capace di controllare il futuro del mondo. L’intelligenza umana formata da coscienza, percezione, auto-percezione potrà mai arrivare ad essere inglobata nella “intelligenza generale artificiale”? La risposta che arriva è negativa, né potrà esserlo in futuro. Papa Francesco in un messaggio inviato a gennaio al summit di Davos in Svizzera ricordava che l’IA è strumento dalle mille potenzialità, ma deve essere messo «al servizio di uno sviluppo più sano, più umano, più sociale e più integrale», altrimenti come tutti gli sviluppi tecnologici, se «non migliorano la vita di tutti» ma «creano o aumentano disuguaglianze e conflitti», non possono essere definiti «vero progresso». In un altro messaggio, stavolta rivolto al presidente francese Macron in occasione del Summit sull’intelligenza artificiale di Parigi, Francesco auspicava la creazione di una piattaforma in cui le nuove tecnologie potessero essere strumento per la lotta alla povertà, protezione delle culture, ecosostenibilità: «Spero che i prossimi vertici considerino in modo più approfondito gli effetti sociali dell’intelligenza artificiale sulle relazioni umane, sull’informazione e sull’istruzione». I robot forse potranno effettivamente essere in grado di acquisire una sorta di coscienza o intelligenza parlando con noi, ma, poiché essi non hanno né corpi né relazioni sociali, la loro intelligenza non potrà mai essere come la nostra e divenire auto coscienza. Forse i cardinali nella Sistina, sotto il soffitto di Michelangelo, si sono concentrati su quella scintilla trasmessa dal Dio creatore ad Adamo proteso con la mano verso il Padre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
© RIPRODUZIONE RISERVATA
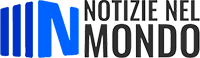
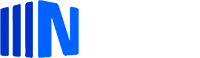



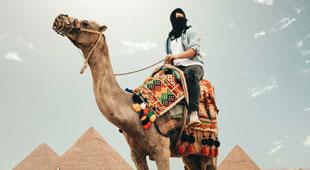









Leave feedback about this