Architetto, urbanista e ingegnere: Carlo Ratti è un protagonista del dibattito internazionale sull’impatto delle nuove tecnologie in campo urbano e sul futuro del concetto di Smart city.
Le città restano straordinari acceleratori di conoscenza, possibilità e innovazione, ma al contempo sono grandi epicentri d’inquinamento della Terra. Qui si gioca sempre più la sfida dello sviluppo sostenibile globale.
«Le città del futuro potrebbero essere più grandi di quelle in cui viviamo ora, ma questo non significa che le piccole città scompariranno – sottolinea Ratti – Credo che il futuro sarà ancora un mosaico di centri di taglie diverse». Mente e anima dello studio internazionale di design Carlo Ratti Associati, l’architetto, nominato curatore della Biennale Architettura 2025, insegna al Massachusetts Institute of Technology (Mit) di Boston, dove ha fondato il Senseable City Lab: «Abbiamo deciso di concentrarci sulla parola “Senseable” perché, nel gioco di parole tra “sensible” e “able to sense” – in italiano potremmo tradurlo come città dei sensi o sensibile – pensiamo si trasmetta un’idea più corretta dei nostri obiettivi rispetto alla Smart city: una città dove al centro ci sono le persone e non le tecnologie. Non esiste un’unica ricetta, ma dobbiamo guardare ai tanti esempi in giro per il mondo: Singapore sta lavorando molto sulla mobilità, Boston sulle dinamiche partecipative, Helsinki sulla decarbonizzazione».
In che cosa consiste il progetto del suo studio nella capitale finlandese?
«“Hot Heart” è uno dei più grandi progetti di decarbonizzazione urbana in corso nel mondo. Si tratta di un arcipelago di bacini termici ancorati al largo della costa di Helsinki, in grado di immagazzinare energia termica prodotta da fonti sostenibili e capace di alimentare il sistema di teleriscaldamento della città. Una piccola parte dell’energia termica, tuttavia, verrà usata per riscaldare la superficie delle isole galleggianti, che andranno così a ospitare, in modo del tutto sostenibile, grandi spazi pubblici e foreste verdi 365 giorni l’anno».
I big data aiutano davvero a rendere più inclusive le città?
«I dati giocano un ruolo importante per farci capire come vive una città, sentire in tempo reale il suo battito cardiaco. Sul tema dell’inclusione, fondamentale, prendo a esempio un progetto che abbiamo sviluppato alla Biennale di Design di Porto, dove abbiamo usato i tweet geolocalizzati e i dati anonimi provenienti dai cellulari di decine di migliaia di persone per provare a mappare le nuove forme della segregazione sociale: quelli che con il sociologo Richard Sennett abbiamo chiamato “ghetti liminali”. Studi del genere possono aiutare amministrazioni a trovare nuove strategie di inclusione».
Oggi le città accolgono oltre il 50% della popolazione mondiale. Quanto “pesano” le nostre case in termini di consumi energetici?
«Lei cita il dato per cui il 50% della popolazione mondiale vive in città. Consideriamo altri tre numeri: 3-75-80. Pur accogliendo cinque miliardi di persone, le città occupano il 3% della superficie terrestre e sono responsabili per il 75% del consumo energetico e per l’80% delle emissioni di CO2. Un bel peso, insomma. Rendere le nostre città più sostenibili è fondamentale per l’equilibrio dell’intero pianeta».
Qual è il significato della “città in un quarto d’ora”?
«Secondo Carlos Moreno, la città dei quindici minuti è la città in cui ogni servizio essenziale è posizionato nell’arco di un quarto d’ora a piedi o in bicicletta. È un’idea molto semplice ma al tempo stesso foriera di grandi cambiamenti – sia per la sostenibilità ambientale che sociale».
È già una realtà?
«Una ricerca che abbiamo condotto al nostro Senseable City Lab e recentemente pubblicata su Nature Human Behavior — usando dati di geolocalizzazione anonimizzati di 40 milioni di americani, andando a misurare la frequenza con la quale i residenti di un certo quartiere svolgessero attività essenziali nel raggio di un quarto d’ora — ci dice che le persone si organizzano già in una informale “città dei 15 minuti” nei casi in cui servizi come parchi e negozi di alimentari siano disponibili entro quell’arco temporale».
Quale dovrebbe essere il futuro delle automobili nelle città congestionate dal traffico?
«Vedo un futuro sempre meno legato alle auto di proprietà e più a forme di mobilità leggera (dalla bici al monopattino) con al centro il caro vecchio trasporto pubblico reso di nuovo efficiente con investimenti e capacità di pianificazione.
Per dirla con il presidente colombiano Gustavo Petro: «Un Paese è sviluppato non quando i poveri possiedono automobili, ma quando i ricchi usano mezzi pubblici e biciclette».
Dove andrebbero indirizzati gli investimenti per un nuovo sviluppo sostenibile delle città?
«Non costruire nuove città, ma far funzionare meglio quelle che ci sono. Mi spingerei oltre – io porterei a zero il consumo di suolo in tutto il Paese. Il che non vuol dire non fare più nulla. Anzi, vuol dire lavorare per mettere a posto quello che c’è e restaurare o costruire su terreni già utilizzati in passato».
Nella ricerca del verde c’è una tendenza che prende piede in varie città italiane del lasciarlo crescere. Quanto è distante il sogno di avvicinare la città alla libertà della natura?
«Direi che la principale sfida in architettura oggi sia avvicinare il naturale all’artificiale. Per dirla con le parole del geografo anarchico francese Elysée Reclus: “L’uomo dovrebbe avere il doppio vantaggio di un accesso ai piaceri della città e, allo stesso tempo, poter godere la libertà che si trova nella libertà della natura”».
Dove sta conducendo la sfida del marketing urbano che spinge a costruire architetture iconiche costose fini a sé stesse?
«Da nessuna parte, o meglio, da nessuna parte positiva. Ricordiamo cosa diceva Paul Ricoeur già negli anni Sessanta: “Ormai troviamo dappertutto gli stessi film di bassa qualità, le stesse slot machine, i medesimi orrori di plastica o alluminio”. La vera sfida è riuscire a rispondere al contesto – a partire dalla sfida climatica. È la sfida più grande che dobbiamo affrontare, e verso cui dobbiamo concentrare tutte le nostre intelligenze. È quello che cercheremo di fare alla Biennale Architettura 2025».

A proposito d’infrastrutture, parliamo di quelle necessarie ed ecosostenibili. Come avete immaginato la ricostruzione del ponte Francis Scott Key Bridge collassato a Baltimora?
«Dopo lo sconcerto per la tragedia umana, insieme all’ingegnere francese Michel Virlogeux, tra i maggiori esperti in materia al mondo, abbiamo ipotizzato un ponte strallato che permette di posizionare le pile lontano dal canale di navigazione utilizzato dalle grandi navi. Questo scongiura il rischio che si ripeta una tragedia come quella del 26 marzo scorso. Inoltre, abbiamo deciso di optare per una soluzione a ridotto impatto ambientale: leggera in modo da ridurre il consumo di materiali e capace di produrre energia mediante pannelli fotovoltaici».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
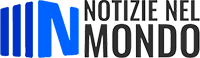
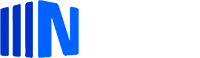



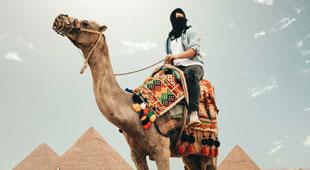









Leave feedback about this